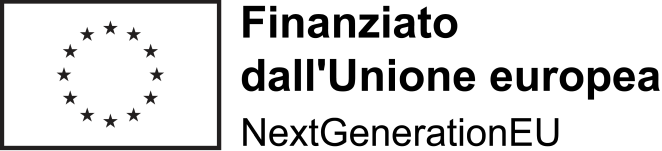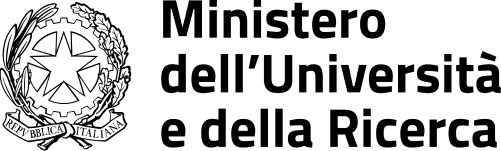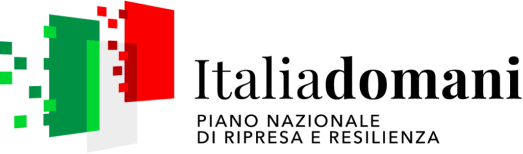Pubblicato il: 13-5-2025
Condividi
Condividi

Le ragioni di questa vulnerabilità sono legate alla caratteristica variabilità climatica e morfologica del Mediterraneo, in termini di pressione atmosferica, temperatura e livelli di precipitazioni, che aumentano l'esposizione della stessa a disastri ambientali.
Il lavoro presentato nell’articolo scientifico Balancing climate policies and economic development in the Mediterranean countries, pubblicato su Energy Economics a maggio 2025, è a cura di:
Marta Castellini
Dipartimento di Economia e Management Marco Fanno, Università di Padova, Italia
Fondazione Eni Enrico Mattei, Italia
Camilla Gusperti
Fondazione Eni Enrico Mattei, Italia
Veronica Lupi
Institute for Environmental Studies, Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
Fondazione Eni Enrico Mattei, Italia
Sergio Vergalli
Dipartimento di Economia e Management, Università di Brescia, Italia
Fondazione Eni Enrico Mattei, Italia
Chiara Castelli
Wiiw - the Vienna Institute for International Economic Studies, Vienna, Austria
Department of Economics, WU - Vienna University of Economics and Business, Vienna, Austria
Diversi studi scientifici mostrano che, nel corso del XXI secolo, l’area del Mediterraneo sarà soggetta ad un significativo stress climatico, accompagnato da un aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi, come ondate di calore, siccità o inondazioni.
In termini economici, questo shock climatico si tradurrà in perdite di benessere che penalizzeranno le economie con una forte dipendenza dalle risorse naturali e una limitata capacità tecnica e finanziaria di attuare strategie di mitigazione e adattamento su larga scala, soprattutto nelle zone meridionali e orientali del bacino.
Al fine di comprendere più a fondo l’impatto economico di tale cambiamento per i paesi del Mediterraneo, considerando diversi scenari di crescita futura e diversi obiettivi climatici, lo studio utilizza un modello di ottimizzazione intertemporale regionale che unisce la componente economica e produttiva della società a quella ambientale e climatica, chiamato RICE-99 di Nordhaus e Boyer (2000).
Questo modello permette di aggiornare i dati storici al fine di offrire previsioni in linea con le attuali politiche climatiche e di adattare la regionalizzazione ad un dettaglio spaziale più granulare, al fine di ottenere indicatori socio-economici per tutti i paesi del Mediterraneo e valorizzare monetariamente i danni ambientali generati dal cambiamento climatico.
Questa nuova versione del modello viene presentata come “RICE-MED” e permette di generare proiezioni fino al 2100 per indicatori sia globali, quali l’incremento della temperatura globale rispetto ai livelli preindustriali e il costo sociale del carbonio, che nazionali per i paesi del Mediterraneo, come il prodotto interno lordo, il consumo, gli investimenti, il consumo di energia e le emissioni industriali derivanti dalla produzione di energia mediante fonti fossili.
Quando il modello simula lo scenario di raggiungimento del target climatico — ovvero contenere l’incremento della temperatura al di sotto dei 2°C rispetto ai livelli pre-industriali entro la fine del XXI secolo — il costo sociale del carbonio è pari a 200 USD per tonnellata nel 2055, e raddoppia entro la fine del secolo. In tale contesto, i paesi del Mediterraneo caratterizzati da livelli di reddito bassi e localizzati nel sud del bacino sono soggetti alle perdite economiche più elevate. Se il contesto economico mondiale mantiene il proprio percorso lontano dalla transizione ecologica, ovvero adottando un’ attitudine business as usual, la soglia di incremento pari a +1.5°C verrà raggiunta entro il 2055.
Il modello è contraddistinto da un modulo economico composto da tutte le economie del mondo aggregate in diverse regioni, ad eccezione dei paesi del Mediterraneo, che interagisce con un modulo climatico globale.
Le proiezioni generate sono costruite in un contesto socio economico comune ad ogni regione, che al contempo è però caratterizzata da una calibrazione dedicata al fine di allinearsi, nell’inizializzazione, ai dati storici dell’anno base, ovvero il 2015, ed alle esigenze tecniche del modello teorico di crescita impiegato, nonché alle prospettive di crescita economica futura.
L’interazione tra i due moduli avviene attraverso l’impiego di energia generata da fonti fossili per la manifattura di beni. Tale consumo produce emissioni di gas climalteranti che fluiscono nel modulo climatico, utilizzato per calcolare l’incremento della concentrazione di anidride carbonica nell’atmosfera e della temperatura rispetto ai livelli pre-industriali.
Le emissioni che permangono nell’atmosfera, contribuiscono ad aumentare la temperatura media globale, input fondamentale della funzione di danno climatico. La relazione tra emissioni prodotte dalle economie dei paesi e sensitività climatica permette di calcolare il costo dell’esternalità indotta dal cambiamento climatico, in termini di perdita di PIL e, quindi, in termini di crescita economica futura.
Le economie mondiali producono utilizzando capitale, lavoro ed energia, quest'ultima generata esclusivamente da fonti fossili come carbone, petrolio e gas naturale. Il progresso tecnologico è esogeno, sia per la manifattura dei prodotti finiti che per la creazione di energia, e nessuna tecnologia ad alto beneficio ambientale è prevista.
La riduzione delle emissioni può avvenire solamente attraverso un adattamento dei consumi. La popolazione è anch’essa esogena ed evolve calibrata secondo le proiezioni demografiche dell’ International Institute for Applied Systems Analysis nel contesto dello scenario SSP2-RCP4.5, ovvero assumendo un futuro caratterizzato da rilevanti sfide di mitigazione ed adattamento.
Produrre energia da fonti fossili ha un costo monetario che viene pagato con una porzione del PIL, e tale costo è caratterizzato da:
Il modello ha come anno di riferimento il 2015 e fornisce risultati ogni 10 anni fino al 2105. La scelta dell’intervallo temporale è legata alla scienza del clima che spiega come serva indicativamente quell’arco di tempo perché il consumo si traduca in una conseguenza fisica nel ciclo del carbonio.
Le diverse economie del mondo vengono aggregate in macro-regioni secondo il principio di omogeneità nel livello reddituale, ad eccezione delle nazioni del Mediterraneo che invece vengono mantenute a livello paese al fine di avere risultati più dettagliati a livello spaziale.
Nel dettaglio, le macro-regioni del modello sono otto, ovvero: Stati Uniti, Cina, Europa, altri Paesi ad alto reddito (OHI), Russia ed Europa dell’est (EE), Paesi a reddito medio (MI), a reddito medio basso (LMI) ed a reddito basso (LI), più i 20 paesi del Mediterraneo, ovvero Albania, Algeria, Croazia, Cipro, Egitto, Etiopia, Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Montenegro, Marocco, Spagna, Sudan, Siria, Tunisia e Turchia.
I risultati del modello sono creati secondo diversi scenari di crescita futura. Il primo, definito come “Business as usual”, rappresenta un contesto nel quale non vi siano cambiamenti nelle politiche legate al clima ed gli effetti dei costi dei danni climatici non mitigati.
Il secondo, “Social Optimum”, prevede la massimizzazione della funzione di benessere sociale sotto i vincoli economici e climatici, identificando i percorsi ottimali di riduzione delle emissioni in ogni momento. I costi e i benefici marginali vengono equiparati, bilanciando i danni climatici e gli sforzi di mitigazione.
L’ultimo scenario considerato è quello che comprende un vincolo al limite della temperatura raggiungibile al 2100 pari a +2°C rispetto i livelli pre-industriali. Questo scenario è idealmente più vicino all'obiettivo dell'accordo di Parigi.
Gli indicatori che vengono ottenuti a livello globale sono tutti quelli afferenti al modulo climatico, essendo lo stesso “non regionale”, ovvero forze radianti, concentrazioni nei diversi serbatoi di CO2, dinamica della temperatura globale, nonché il costo sociale del carbonio, utilizzato anche come riferimento per valorizzare la carbon tax.
Quest’ultimo ha un valore medio (2015-2100) di 231.32 USD/tC nello scenario di Social Optimum, permettendo il raggiungimento di un incremento di temperatura alla fine del secolo pari a +2.29°C. Se viene invece imposto un obiettivo climatico pari a +2°C al 2100, il valore medio dal costo sociale del carbonio raggiunge 1728.41 USD/tC.
L’analisi regionale si focalizza principalmente sugli indicatori economici, quali la dinamica del consumo e di quello energetico, la perdita economica indotta dagli effetti del cambiamento climatico, gli investimenti o l’intensità di emissioni per unità di prodotto interno lordo generata.
Le regioni con redditi più bassi (tra cui i paesi dell’Africa centrale, ad esempio) subiscono le perdite maggiori in termini di crescita quando il costo del cambiamento climatico viene internalizzato, riflettendo la potenziale vulnerabilità delle economie meno sviluppate alle politiche ambientali.
Stati Uniti e Cina subiscono anch’esse perdite crescenti rispetto all’austerità degli scenari. Per quanto riguarda i paesi europei, esclusi quelli appartenenti al Mediterraneo, alcuni scenari suggeriscono che il bilanciamento tra costi (danni ambientali non mitigati) e benefici (danni ambientali evitati grazie alle politiche climatiche) potrebbero portare a guadagni economici positivi in termini di crescita nel lungo periodo.
Nel contesto del Mediterraneo, i paesi che performano meglio in termini di tasso medio di crescita annuale sono Algeria, Egitto, Etiopia, Libia, Marocco, Sudan e Tunisia. Nel confronto tra scenari che internalizzano l’effetto del cambiamento climatico, l’Etiopia spicca come caso virtuoso, mentre Libia e Tunisia sono tra i peggiori.
Nel complesso, una prospettiva futura limitata solo al miglioramento nella gestione del consumo di energia ed alla costante crescita economica, quindi poco incisiva nell’ambito della transizione energetica e del progresso tecnologico connesso ad essa, evidenzia la complessità di combinare lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale, amplificando le disparità regionali indotte dalla crisi climatica.
Politiche climatiche più ambiziose (scenario limite alla temperatura), e progressi tecnologici comunque in evoluzione, potrebbero portare a miglioramenti sostanziali nell'efficienza energetica, soprattutto nei Paesi ad alto reddito.
Queste ultime, insieme a quelle a medio reddito medio, subiscono però le maggiori fluttuazioni tra gli scenari, evidenziando lo sforzo necessario per conformarsi alle politiche climatiche che mirano a fissare un prezzo del carbonio elevato per rispettare l'obiettivo climatico. Al contrario, regioni a basso e medio reddito (LI, LMI ed EU) mostrano una più forte flessione.
Per quanto riguarda il tasso di crescita dell'intensità energetica dell'Europa, esso potrebbe riflettere l’impegno verso gli obiettivi climatici e lo sforzo di transizione verso un'economia più sostenibile. I paesi del Mediterraneo, nel loro complesso, mostrano un rallentamento nell'uso dell'energia, riducendo il tasso di crescita o sostituendo altri input, come capitale e lavoro, o sfruttando anch’essi miglioramenti tecnologici che possono ridurre le emissioni per unità di prodotto.
In tale contesto, l’Italia ad esempio, insieme a Francia, Spagna e Malta, si colloca nel gruppo di paesi caratterizzati da una riduzione tra l’1.30% al 2.5%, ad eccezione dell’ultima che raggiunge il 4% nello scenario più stringente in termini di politica climatica.
I risultati dello studio mostrano come, in un contesto dove la transizione ecologica viene ritardata significativamente ed il progresso tecnologico nell’ambito della neutralità carbonica è assente, le economie mature, quali gli Stati Uniti, potrebbero subire un rallentamento economico qualora il sistema mondiale internalizzasse completamente il costo del cambiamento climatico.
Al contrario, economie come la Cina potrebbero subire effetti meno negativi, mantenendo comunque tassi di crescita positivi. Le regioni economiche avanzate avrebbero comunque l’onere di superare quelle meno avanzate nella riduzione dell'intensità delle emissioni, puntando ad una maggiore efficienza nella produzione nel suo complesso, e quindi migliorando tecnologicamente al fine di contenere il proprio l’impatto ambientale.
L’analisi dei paesi del Mediterraneo evidenzia l’eterogeneità delle risposte alle politiche climatiche. Sebbene tutti questi paesi mostrino una riduzione dei consumi energetici per la produzione di beni nello scenario più stringente, l'entità varia, riflettendo le diverse caratteristiche nazionali e le capacità di mitigazione. Secondo le proiezioni, i paesi mediterranei economicamente avanzati registreranno una riduzione più significativa nell'uso dei servizi energetici, in linea con i loro impegni verso gli obiettivi climatici e la transizione economica sostenibile.
Lo studio mostra la complessa interazione tra politica ambientale, crescita economica e consumo energetico. Una politica climatica aggressiva è necessaria per mantenere l'aumento della temperatura globale al di sotto dell'obiettivo dei 2°C, ma comporta impatti e oneri economici diversi a seconda delle regioni e dei paesi.
La letteratura scientifica che studia la disuguaglianza delle emissioni di carbonio mostra che non tutti i paesi sono ugualmente responsabili dell'esaurimento del bilancio globale del carbonio. Le economie sviluppate, in particolare, hanno una responsabilità storica per l'attuale crisi climatica.
Il percorso di crescita futura diventa quindi ancora più complicato considerando la difficoltà di combinare responsabilità storiche ed ambientali, nonché garantire possibilità di eque condizioni di vita tra territori e generazioni.
Tre Modelli per le Comunità Energetiche di area vasta: Cooperativa, Associazione o Fondazione?
Analisi comparata di tre esperienze concrete di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) di area vasta: dal rigoroso percorso cooperativo di Livorno alla flessibilità assoc...
Stimare le emissioni di CO2 nel settore elettrico: confronto tra metodi e una riflessione di policy
I metodi per stimare le emissioni di CO2 provenienti dai diversi settori industriali sono classificati dall’IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change a seconda de...
La ricerca condotta sul Campus Universitario di Palermo dimostra come interventi di retrofit ed energie rinnovabili possano coprire fino all’80% del fabbisogno annuo. La ...
Paola Valbonesi, Direttrice Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno", Università di Padova e coordinatrice dello Spoke 6 di Grins, e Marta Castellini,...
2025
2025
Cosa c’è dietro la transizione ecologica? Una call for papers per Rethinking Clusters 2025
Dal 23 al 26 novembre 2025, l’Università di Vale do Itajaí (UNIVALI), in Brasile, ospiterà l’ottava edizione della conferenza internazionale “Rethinking Clusters”, dedica...
2025
2025
Dati, sostenibilità e innovazione: due workshop all’Università di Ferrara
L’8 e il 10 settembre 2025, l’Università di Ferrara ospiterà due giornate di studio su strategie aziendali, impatto socio-economico e contabilità ambientale. Call for pap...
Uno studio condotto dal team di Unisalento (Progetto BAC ECOPOL ENAL) indaga la discrepanza tra l’impatto ambientale reale e quello percepito di alcuni comportamenti sost...
Dietro le quinte delle Comunità Energetiche: cosa racconta davvero la ricerca?
Le comunità energetiche sono celebrate come modelli sostenibili e inclusivi. Ma un'analisi critica della letteratura scientifica rivela contraddizioni profonde tra retori...
Le famiglie italiane e le Comunità Energetiche Rinnovabili: tra interesse e barriere informative
La ricerca su 15.000 famiglie italiane rivela un forte interesse verso le energie rinnovabili. Eppure, il 35% non ha mai sentito parlare delle Comunità Energetiche. Come ...
2025
Filiere agroalimentari sostenibili: il workshop TESSERE a Foggia
Il 13 giugno 2025, presso l’Aula Magna del DEMeT, si terrà il workshop dedicato alla Tematica 7 del progetto TESSERE, nell’ambito dello Spoke 6, WP4.
2025
2025
Un team dell’Università di Palermo parteciperà all’ International Congress on Sustainable Energy and Related Technologies. Il loro studio propone strategie efficaci per l...
Aria purificata in classe: così si riducono le assenze scolastiche
Uno studio sperimentale condotto in scuole primarie milanesi dimostra che i purificatori d'aria riducono l'inquinamento indoor del 32% e le assenze scolastiche del 12,5%,...
Povertà energetica e intelligenza artificiale: il punto a Focus ESG
La professoressa Paola Valbonesi, il professore Stefano Bonetti e l’ingegnere Edoardo Agostini sono intervenuti a ESG per parlare di povertà energetica e soluzioni innova...
Ottimizzazione di Percorsi nel Directed Chinese Postman Problem con Ant Colony Optimization
L’articolo esplora l'applicazione dell'Ant Colony Optimization (ACO) per risolvere il Directed Chinese Postman Problem (DCPP), un problema di ottimizzazione con applicazi...
Mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastici: dove intervenire?
Il gruppo di ricerca dell’Università di Ferrara e dell’Università Cattolica (Spoke 6, WP 1) è impegnato nella mappatura dell’efficienza energetica degli edifici scolastic...
2025
2025
Clima e resilienza: la partnership Grins fa il punto sull’adattamento nei sistemi economici
Il 16 maggio si terrà online il workshop “Adaptation for Climate Resilience”, organizzato nell’ambito dello Spoke 6 del progetto Grins. Ricercatori ed esperti si confront...
Verso un ESG sostenibile e democratico per le PMI
I professori Marco Bettiol e Giuseppe Danese dell’Università di Padova, membri dello Spoke 6 WP4, affrontano il tema della rendicontazione ESG per le PMI, proponendo un a...
Le case italiane sotto la lente: un modello innovativo per capire (e ridurre) i consumi energetici
Un nuovo modello open-source simula i consumi energetici degli edifici italiani combinando fisica edilizia e comportamenti degli utenti. Sviluppato nel progetto GRINS, ai...
2025
Interverranno al convegno, per lo Spoke 6, la prof.ssa Silvia Rita Sedita dell’Università di Padova (leader WP 6.3) e la prof.ssa Daniela Baglieri, che appartiene al BAC ...
Il 19, 20 e 21 marzo 2025 si è tenuto a Cortina d’Ampezzo il convegno dal titolo “Transizione sostenibile, competitività e innovazione: il ruolo della Life Cycle Assessme...
Il nuovo indicatore per per mappare e affrontare efficacemente il problema della povertà energetica a livello locale.
Il gruppo di ricerca del Work Package 6.1 dello Spoke 6, nel corso degli ultimi mesi ha pubblicato due policy brief che fanno il punto sulle ricerche svolte finora sotto ...
Il Rapporto Annuale Istat 2024 ha utilizzato per il secondo anno consecutivo la misura dell’Osservatorio Italiano sulla Povertà Energetica (OIPE)
Decarbonizzare, e in fretta: politiche al bivio tra urgenza e rischi di disuguaglianza
L’intervista a Paola Valbonesi, coordinatrice di Spoke 6 e WP 6.4. In collaborazione con Laura Bonacorsi (research manager Spoke 6), Cristina Cattaneo (coordinatrice WP ...
Fonti rinnovabili. Servizi a KM0 delle comunità energetiche
Un’introduzione al concetto di servizi di flessibilità per il sistema elettrico: come coinvolgere le comunità energetiche in questo mercato.
Comunità Energetiche: oltre i decreti, le vere sfide
Estratto dell'articolo di Marina Bertolini e Marta Castellini (Università di Padova) pubblicato da Equilibri Magazine su integrazione sistema elettrico, cambiamento dei c...
Fare rete per ridurre le emissioni di CO2. È l’obiettivo del bando a cascata, aperto fino al 21 dicembre, lanciato dall’Università di Padova capofila dello Spoke 6.
2023
2023
Lo Spoke 6 si riunisce all'Università di Padova per il suo kick-off meeting
Si terrà il 20 e 21 novembre all'Università degli Studi di Padova il primo incontro dei partecipanti allo Spoke 6.
Fondazione GRINS
Growing Resilient,
Inclusive and Sustainable
Galleria Ugo Bassi 1, 40121, Bologna, IT
C.F/P.IVA 91451720378
Finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 (Infrastruttura e ricerca), Componente 2 (Dalla Ricerca all’Impresa), Investimento 1.3 (Partnership Estese), Tematica 9 (Sostenibilità economica e finanziaria di sistemi e territori).